Il linguaggio costruisce, non solo comunica
Il nostro linguaggio non è solo la lingua che parliamo. E non è nemmeno una linea retta che va da chi parla a chi ascolta. Assomiglia invece molto più a un labirinto in cui ci dobbiamo costantemente orientare.
Tutti parliamo, scriviamo e leggiamo nella stessa lingua. Allora perché è così difficile capire e farsi capire, dentro e fuori dall'azienda? Condividiamo lingua e contesto, eppure, ancora oggi, ci incartiamo sui volevo dire, non hai capito, cosa intendi?, io pensavo che. Eppure, ancora oggi, ogni problema finisce sempre per essere un problema di comunicazione. Perché?
Per rispondere a questa domanda negli ultimi anni ci siamo concentrati sull’importanza delle parole e del modo in cui le combiniamo, trascinati dalla consapevolezza che la lingua filtra i pensieri e guida le azioni. La strada è quella giusta, ma la mia esperienza mi dice che in azienda si lavora ancora troppo poco sul linguaggio. Forse perché parlare è una cosa talmente naturale che storciamo il naso al pensiero di doverci formare ed allenare per analizzare i nostri discorsi; e poi, c'è lo spauracchio del tempo che manca e delle priorità da evadere.
Però, se continuiamo a fare così fatica a capirci, se rientriamo a casa frustrati perché abbiamo detto A e il cliente ha capito B o se ci troviamo incastrati in riunioni fiume da cui usciamo pensando non parliamo la stessa lingua…. allora forse vale la pena fermarsi un attimo e capire perché è così importante costruire competenze attorno al linguaggio. A partire dalla voce di chi, ben prima di noi, ne ha affrontato la complessità e ha cercato di darci qualche insegnamento.
Due su tutti, per iniziare.
Il linguaggio è un labirinto di strade. Vieni da una parte e ti sai orientare, giungi allo stesso punto da un’altra parte e non ti raccapezzi più.
Diceva Ludwig Wittgenstein.
Le parole, con i loro grappoli di accezioni e le loro valenze emotive e memorie, sono nuclei di condensazione di usanze, costumi, credenze, pratiche operative, ricerche teoriche, filosofiche.
Diceva Tullio De Mauro.
Due su tutti, per dire che nelle parole ci sono mondi infiniti e a volte - anche se pensiamo di conoscerle bene - ci smarriamo in un labirinto di significati.
Il linguaggio dunque è ben più che trasferire informazioni. E allora che cos'è? Beh, come prima cosa sgomberiamo il campo da un fraintendimento: il linguaggio non è (solo) la lingua che parliamo.
Lingua o linguaggio?
La nostra lingua - come tutte le lingue - è un codice che serve a rappresentare le cose. Un codice formato da segni simbolici (parole, ma anche numeri e nomenclature varie) e da regole di applicazione che ci dicono come usarli bene.
La nostra lingua - come tutte le lingue -è una espressione del linguaggio, ma non lo esaurisce. Il linguaggio è qualcosa di più della lingua che parliamo; qualcosa che ci ha permesso di fare innumerevoli cose, fino ad inventarci - letteralmente - nuovi codici.
Cosa possiamo fare con il linguaggio?
Parole, numeri e simboli sono tutti segni che esprimono e rappresentano la realtà. E se è vero che il nostro cervello è nato per vedere - e non per leggere - è facile capire perché nella storia i primi segni che abbiamo creato erano dei disegni. Cioè dei segni-di quello che dovevamo rappresentare, così come era, per trasmettere un messaggio veloce e chiaro. Con i disegni abbiamo imparato a denotare, ad indicare le cose in modo oggettivo e non interpretabile. [Tecnicamente questa è la funzione denotativa del linguaggio].

Poi è arrivata la scrittura: i segni hanno perso la corrispondenza con la forma delle cose (la parola“casa” non ha nulla della forma di una casa) e noi abbiamo imparato ad astrarre un concetto e a rappresentarlo. Cosa non da poco, perché da allora abbiamo iniziato a connotare, cioè a caratterizzare le cose con associazioni e sfumature soggettive: se scegliamo la parola “casa” invece di “abitazione” è perché vogliamo esprimere un significato certamente più personale. [Questa si chiama funzione connotativa del linguaggio].
Sono entrati così in gioco il contesto e il significato; e con loro anche le nostre interpretazioni: perché se è vero che il codice linguistico serve a metterci d’accordo sul significato delle parole, è vero anche che spesso ciò che una espressione ‘dice’ convenzionalmente non corrisponde a ciò che si ‘vuole dire’ (o intendere) con quella espressione. Paul Grice a questo proposito parla di significato convenzionale e situazionale per spiegare perché ogni giorno ci scontriamo con impliciti e incomprensioni.
Insomma, per capirsi non basta condividere un codice e dei significati; anche perché per spiegare il significato di una parola usiamo definizioni e parafrasi che presto o tardi ci rimandano alla parola che dobbiamo spiegare.
Umberto Eco lo ha chiamato principio di indeterminazione del linguaggio:
[...] parlare degli atti di parola, significare la significazione, o comunicare circa la comunicazione, non possono non influenzare l’universo del parlare, del significare, del comunicare.
Vale a dire: tutto ciò che diciamo cambia mentre lo diciamo e proprio perché lo stiamo dicendo. Come se le parole fossero in un flusso continuo di significazione, per cui è impossibile stabilire significati univoci; non tanto per i diversi contesti in cui le usiamo, ma per come le usiamo.
Ma non c'è da scoraggiarsi, anzi! Perché il tentativo di governare questo flusso ci ha portati dritti dritti alla cosa più straordinaria che abbiamo imparato a fare con il linguaggio: ci siamo inventati i linguaggi formali! Abbiamo capito cioè che oltre ai segni e alle regole di applicazione, il linguaggio ha delle regole d'uso. Proprio quelle regole che cambiano il valore delle parole, in base a come le usiamo. E allora, stanchi di rincorrere il vortice delle interpretazioni e spinti dal bisogno di avere una conoscenza solida, abbiamo deciso di blindare queste regole e creare i linguaggi che ci servivano. Lo abbiamo fatto con la matematica, con la chimica, con la fisica e l'informatica, congelando il valore e le regole dei loro simboli - "2", "H₂O" "π"- a prescindere da chi e quante volte li usa.
E quante cose siamo riusciti a creare così! Quanti mondi, quanta conoscenza, quanta innovazione!
Ma che dire del nostro linguaggio quotidiano, ci sono regole che possiamo formalizzare? Di sicuro ci sono regole che possiamo iniziare a far emergere.
Il significato di una parola è il suo uso nel linguaggio
È di nuovo Wittgenstein a prenderci per mano, per non farci smarrire nel labirinto.
È solo in base all'uso che possiamo conoscere il significato. Non ci sono definizioni né contesti a mettere recinti, questa è la funzione ostensiva del linguaggio. Ostendere, una parola poco usata ma che presto possiamo tradurre in mostrare, esibire, dispiegare ciò che altrimenti risulterebbe implicito e fraintendibile; ed è proprio mostrando le regole d’uso che capiamo il valore delle parole.
Parole che possono descrivere, giudicare, domandare, promettere, comandare: questa casa è un inferno!dice cose molto diverse sulla "casa" da questa casa è composta di due piani, tre camere da letto, un giardino con piscina. In altre parole, c'è una bella differenza tra giudicare e descrivere qualcosa, ma il nostro senso comune - per dirla con Walter Ong - prima parla e poi analizza ciò che ha detto.
Ecco perché è così importante saper analizzare ciò che diciamo ma soprattutto come lo diciamo. Per imparare a scegliere come dire le cose, senza farci trascinare dalle cose da dire.
Il linguaggio costruisce
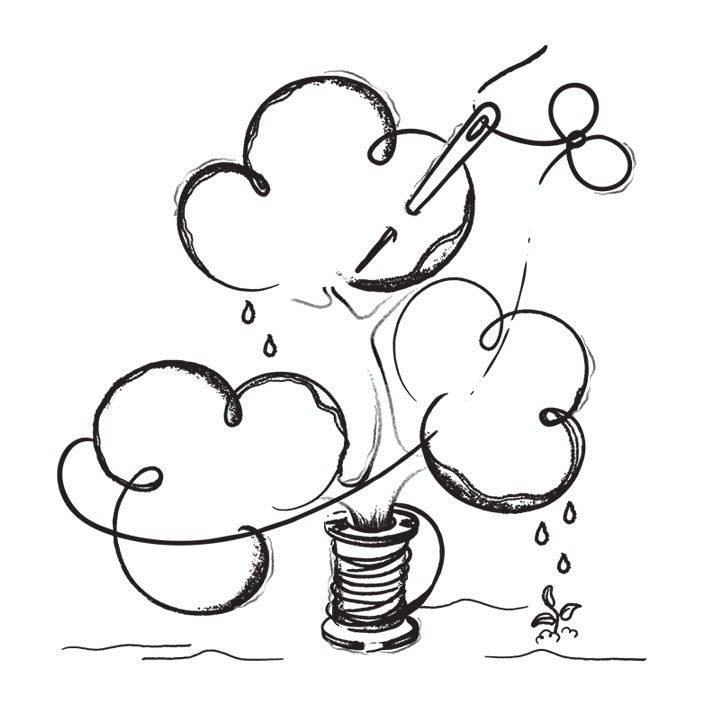
La varietà delle regole d'uso ci insegna che il linguaggio costruisce, non solo comunica; ci insegna, soprattutto, che non esistono problemi insormontabili, conflitti ingestibili o situazioni irreparabili: c'è sempre un modo diverso, nuovo, più efficace per dire le cose.
Conoscere il linguaggio vuol dire questo: scegliere quali regole usare, per l'obiettivo che abbiamo, per le conseguenze che vogliamo ottenere, per le relazioni che vogliamo costruire. Vuol dire essere consapevoli che sbottare dicendo non so più come dirglielo! è un giudizio, una regola che fa morire il dialogo, invece che tenerlo vivo.
Spesso commettiamo l’errore di pensare che sia sempre l'altro a non capire. Iniziamo invece a lavorare su di noi, per farci capire:
- chiedere - invece di supporre
- descrivere - invece di giudicare
- riportare la discussione all'obiettivo - invece di farsi trascinare dalle parole
- condividere criteri di valutazione - invece di imporli
Sono piccoli esercizi che possiamo fare solo se siamo in grado di riconoscere tutti questi modi.
Che senso ha parlare di linguaggio in azienda?
Parlare di linguaggio in azienda ha senso eccome! Perché anche il processo più automatizzato che c'è, presto o tardi, finirà in mano a persone che in qualche modo dovranno parlarsi. Perché ancora oggi diciamo che abbiamo problemi di comunicazione. E perché l’azienda ha le sue regole, convenzioni e codici di comportamento su cui si basano relazioni, decisioni, confronti e obiettivi.
Tutte cose che, neanche a dirlo, facciamo con il linguaggio.
Come si fa a lavorare sul linguaggio in azienda?
Si può iniziare da quattro semplici regolette, per costruire un po' di consapevolezza in più:
- il cosa diciamo dipende da come lo diciamo
- ci sono modi che chiudono e modi che aprono al dialogo
- non ci sono parole giuste o sbagliate, ma parole più o meno pertinenti all'obiettivo
- e al ruolo che abbiamo
Avere un obiettivo, un ruolo, dei valori, una cultura, delle regole di comunicazione e un modello operativo, aiuta di certo... ma non basta!
Serve anche costruire e allenare competenze:
- di analisi del testo: sto descrivendo o giudicando? sto valutando o affermando in modo perentorio?
- di comunicazione efficace: quale modo mi aiuta di più a raggiungere il mio obiettivo?
- di analisi del ruolo: sto facendo parlare il mio ruolo o il mio istinto?
Ecco, in chiusura, cosa possiamo - e dobbiamo! - fare con il linguaggio in azienda: renderlo una competenza. Altrimenti la nostra comunicazione continuerà ad essere situazionale, difficile, inefficace, lenta e poco costruttiva.
Un labirinto di strade in cui rischiamo di perderci.

Condividi

Lascia il tuo commento
Grazie!
Il tuo commento sarà visibile a tutti tra qualche minuto.
Ouch...
Qualcosa è andato storto. Per favore segnala il malfunzionamento a annagirardi@mail.com